Secondo il filosofo Etienne Turpin – esperto di sistemi urbani complessi, estetica e cultura visiva – dell’espansione del consumo ne scrivevano già all’inizio del XX secolo pensatori quali Rosa Luxemburg e Jakob von Uexkull, quest’ultimo considerato uno dei padri dell’ecologia. Nel tempo poi la parabola del consumo si è progressivamente allargata sino ad arrivare a una accumulazione di prodotti che, nella società contemporanea, non risponde più a un’etica di necessità conducendo l’individuo a uno sconsiderato sfruttamento delle risorse naturali in tempo reale. Questo tipo di consumo non si relaziona più con quelli che riteniamo essere i nostri bisogni veri, è un accumulo che resta al di fuori di noi, potremmo quasi dire che si tratta di un consumo che non ci appartiene.
Come si inserisce il “cibo” in questo contesto?
La Fondazione MAST. di Bologna dedica a questo tema delicato, controverso e fondamentale per la vita del Pianeta e dei suoi abitanti, la sua V Biennale di Fotografia dell’Industria e del Lavoro. Il tema è delicato perché, per il principio secondo il quale “siamo ciò che mangiamo”, l’attenzione si rivolge alla trasformazione delle abitudini alimentari inevitabilmente legate allo sfruttamento del territorio che a sua volta determina una trasformazione anche climatica. Controverso perché il comportamento dell’uomo, sempre più convinto di essere “altro” rispetto al naturale e dunque altro rispetto anche all’idea di farne parte, appare quantomeno contraddittorio circa il voler rispettare la natura e al contempo non sapere come fare a rinunciare alle coltivazioni e agli allevamenti intensivi utili a sfamare una popolazione mondiale in costante crescita. Infine il tema è fondamentale poiché questa sorta di schizofrenia condurrà la specie umana sempre più verso un baratro per evitare il quale l’inversione di rotta non è più praticabile almeno non attraverso il semplice cambiamento comportamentale.

© Bernard Plossu
Quanto prendiamo dal mondo che ci circonda, quanto “costa” in termini di risorse vivere giorno per giorno? È un esercizio molto semplice da fare che aiuta ad avere consapevolezza di quanto consumiamo scoprendo che non riguarda soltanto i prodotti materiali che acquistiamo ma tutta la catena di attività ben più allargata della quale non ci rendiamo conto perché siamo al suo interno.
La Terra è viva tanto quanto l’uomo, Gaia è una divinità, la vera rivoluzione è il ricorso a riconoscere le sovrapposizioni. La vita del Pianeta comincia quando le acque e la terra si separano tuttavia i due elementi sono sovrapposti, il limite non c’è, Galileo lo ha reso scienza: quando questo arriva siamo già in un’altra forma. L’esistenza è sovrapposizione di tempi, di culture, di luoghi, di segni. Qui sta l’equivoco proiettato dalle varie conferenze mondiali sul riscaldamento globale: non dobbiamo rimediare a qualcosa che deve ancora succedere bensì a qualcosa che è già successo.
Siamo dunque immersi in una realtà che ci è difficile osservare dall’esterno perché ci appare naturale vale a dire che la viviamo dall’interno, non ne percepiamo i contorni e pertanto non possiamo accorgerci degli effetti, non possiamo essere realmente critici nei suoi confronti. Ma mentre la natura ha le proprie difese, una sua plasticità che la rende in grado di ricrearsi, l’uomo sembra invece destinato a fare le spese della propria accelerazione. In questa prospettiva potremmo quasi dubitare dell’idea ecologista secondo la quale il Pianeta debba essere “salvato” dall’operato del genere umano.
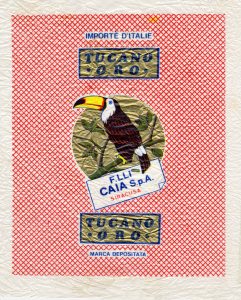
1990 circa. © Fototeca Gilardi
La proposta artistica della Fondazione MAST. si pone, come sempre, in un solco di ricerca che, avvalendosi qui della curatela di Francesco Zanot e di lavori selezionati in diversi paesi e in diverse realtà, mostra come l’immagine fotografica abbia approcciato il Food – titolo di questa edizione tanto esaustivo quanto “alla moda” – nel corso del tempo.
Si parte dalla rigorosa Schokoladenfabrik (1928) di Hans Finsler, autore svizzero tra i più importanti nell’ambito della fotografia industriale del Novecento che mostra un lavoro commissionato dalla fabbrica dolciaria tedesca Most, per passare attraverso la Fototeca di Ando Gilardi con un corpus di immagini tratte da inchieste sull’alimentazione realizzate per il sindacato tra gli anni Cinquanta e Sessanta, fino ad arrivare all’analisi di quel consumo di cui parlavo in apertura trattato dal fotografo belga Mishka Henner con In the Belly of the Beast, insieme di immagini sulla relazione tra l’uomo, la tecnologia e gli animali dove per l’appunto il tema è il consumo indifferenziato e incessante introdotto anche dall’uso stesso che l’autore fa delle immagini, spesso frutto di appropriazioni bulimiche in rete.
La riflessione però non si ferma a questo ambito. Non manca la forma estetica tipica del concetto di natura morta espressa dalla ricerca della fotografa statunitense Jan Groover che con Laboratory of forms – serie di still life realizzati a partire dalla fine degli anni Settanta nella cucina di casa sua – pone l’accento su un concetto tanto semplice quanto evidente: l’idea che «tutto possa essere fotografato, che il contenuto non sia rilevante». E in effetti la forma che pure in queste immagini assume simbolicamente un senso di ordine e caos al contempo, quasi riflettendo il sentimento contrastante che sembra attraversare l’autrice in quel preciso momento della sua vita, si modella sul concetto di ripetitività di una condizione che porta all’essenza pur in apparente “assenza” di senso.

© Henk Wildschut
Anche l’impegno etico-politico è rappresentato attraverso il lavoro di due autori, rispettivamente l’olandese Henk Wildschut e la palestinese Vivien Sansour.
Con Food (2011-2013) Wildschut ci conduce per mano nel cuore della più avanzata ricerca tecnologica applicata all’industria alimentare sempre più regolata dalle normative su igiene e sicurezza promulgate dai governi affinché sia gli allevamenti sia le coltivazioni rispondano a caratteristiche di ampliamento della produzione cercando al contempo di far convivere leggi di mercato (il profitto) e etica (la salvaguardia della salute dell’uomo insieme a una vita più naturale di piante e animali seppure destinati a diventare cibo). Quella di Vivien Sansour è invece una mostra visiva inusuale, non vi sono infatti immagini da guardare appese alle pareti ma una cucina allestita di tutto punto, con tanto di tavola imbandita per almeno quindici persone. Ciò che preme alla Sansour – antropologa, artista e ambientalista, fondatrice della Palestine Heirloom Seed Library, un progetto di arte sociale che ha visto la luce nel 2014 – è il recupero, la catalogazione e la preservazione di una serie di “semi” ormai divenuti rari, se non quasi estinti, che appartengono a un preciso casellario culinario e ad antiche tradizioni agricole della sua terra. Il messaggio politico usa qui la metafora dei semi divenuti rari che fecondano la terra con la loro diversità per sottolineare come “l’estinzione” di un popolo possa essere accomunato all’estinzione della terra sulla quale vive, una terra erosa dalle innumerevoli invasioni e appropriazioni, ponendo l’accento sulla resistenza di uomini e donne dignitosamente arcaici nei confronti di un potere che appare arrogantemente moderno e benestante.

Beit Sahour 2017, © Vivien Sansour. Palestine Heirloom Seed Library
Ma due sono le mostre che colpiscono maggiormente, a mio avviso, per come escono dal carattere documentale prevalente per entrare in quello comunicativo a un livello più profondo che pone lo spettatore difronte a delle domande senza risposta, le più importanti, quelle che implicano lo sforzo maggiore. Stiamo parlando di Factory of original desires di Bernard Plossu e M + Trails del giapponese Takashi Homma.
L’erranza è l’elemento di Bernard Plossu ed è riduttivo parlare del suo immaginario descrivendolo come fotografo di viaggio o street photographer. Attraverso le sue immagini Plossu vive l’esperienza dell’incanto del mondo. Nato in Vietnam, vissuto negli Stati Uniti e in Messico, ha attraversato strade e Paesi non per cogliervi “l’attimo decisivo” ma continuamente alla ricerca dell’essere qui e ora, nell’umanità dei gesti piccoli e all’apparenza insignificanti ma che fanno parte dell’esistenza “normale” di ogni individuo. Potremmo associare le sue fotografie alle short stories di Raymond Carver: un quadro essenziale in cui ogni particolare ha la sua ragion d’essere: non serve niente altro. Nelle sue immagini non vi è alcun intento di documentare e nemmeno di narrare, i suoi occhi vedono semplicemente ciò che accade registrandolo sulla pellicola. Anche il cibo, in quanto atto quotidiano, rientra in questa osservazione attenta di luoghi attraversati da individui che non hanno consapevolezza di questo suo guardare perché non si sentono invasi.

© Bernard Plossu
È però nel contesto moderno e armonioso del Padiglione dell’Esprit Nouveau, riproduzione fedelissima dell’originale di Le Corbusier e Pierre Jeanneret, che incontriamo l’esposizione più interessante, quella del fotografo giapponese Takashi Homma il quale ambienta la sua rappresentazione del consumo legato al cibo in un luogo che sembra essere stato creato per riconciliarsi con il mondo.
Attraverso un gioco di specchi e di finestre che affacciano sul giardino esterno della struttura, di stanze in cui lo spettatore è chiamato ad entrare, di scale che deve salire Homma mette in scena due spaccati della medesima civiltà. Il primo (serie di immagini denominate M rappresenta una “catena” di facciate di edifici che accolgono al loro interno il noto marchio americano di fast food McDonald’s. Il doppio arco giallo, M appunto, ricorre su ognuna di esse omologando di fatto ogni luogo a una precisa idea di cibo. È chiaro cosa si trova all’interno del fast food ancora prima di entrarvi e non vi è alcun bisogno di soffermarsi su cosa offre il menù del giorno poiché è uguale a ogni latitudine del mondo. Tutto ciò è molto rassicurante, inoltre non si percepisce nulla dell’origine del cibo che ci viene venduto: la forma, il colore, il gusto fanno sì che tutto assuma un aspetto “gustoso” per gli occhi prima ancora che per le papille. Analogamente le facciate dei negozi, pur trovandosi in luoghi totalmente differenti tra loro, pur appartenendo a diverse strutture architettoniche tipiche di ciascun paese, attraverso la grande M gialla assumono un aspetto irrilevante poiché è il brand a primeggiare per forma e colore, ancora una volta. Dunque il cibo e il marchio sono la stessa cosa e la serialità che li accompagna costituisce un pilastro inscalfibile nelle nostre menti, un totem insostituibile che agisce sul nostro sguardo senza che noi lo si possa più eludere.

© Takashi Homma. Courtesy Galleria Viasaterna, Milano
Il secondo spaccato rappresenta invece il lato “sacro” del consumo poiché rappresenta la morte violenta che soltanto l’estetica giapponese può trasformare in “bellezza”. Come inchiostro che cola sul foglio bianco così il sangue dell’animale abbattuto cola sulla neve candida. Il sangue è quello dei cervi cacciati sulle montagne di Hokkaido che l’autore ha ritratto donando loro una forma al tempo stesso gentile e cruenta.
«C’è una bellezza in queste macchie – ci dice infatti Takashi Homma – che trascende la realtà proiettandoci in un immaginario altro». Come strane infiorescenze le gocce di sangue raggruppate le une accanto alle altre testimoniano un passaggio che non è soltanto fisico – l’animale ferito – ma vieppiù spirituale: la vita che sconfina nella morte. Anche il cervo sarà destinato alla tavola dei suoi cacciatori eppure il gesto di colpirli a morte reca al suo interno un’intenzionalità totalmente differente dalla precedente, quella di trovarsi faccia a faccia con un essere vivente che sta per morire sapendo che saremo noi a decidere come e quando. Ancora una volta l’Uomo si pone al di fuori della Natura.

Padiglione dell’Esprit Nouveau, Bologna, 2021
L’immagine più emblematica di questo passaggio è posta, in modo estremamente significativo, all’interno di una nicchia che ancora una volta gioca con il rimando di uno specchio: lo spettatore è chiamato a osservarlo osservandosi, diventandone parte integrante. Il paesaggio innevato appare “bucato” dai pallettoni dei cacciatori cui Homma ha chiesto di sparare simboleggiando così non soltanto la morte dell’animale e del luogo in cui la scena sacrificale si compie ma anche la colpa di chi guarda senza agire, ovverosia noi, un po’ come giocare a un tiro a segno in cui il soggetto da colpire siamo noi medesimi. Analogamente potremmo interpretare quest’opera come il tentativo di far morire l’immagine che nulla può più contro un sistema divenuto naturale. Ma l’immagine non si può far morire poiché essa rappresenta l’immaginario, dunque sarà sempre lei che bucherà i nostri occhi. Fino a quando qualcuno non ucciderà anche l’immaginario.

Padiglione dell’Esprit Nouveau, Bologna, 2021




