Con l’arrivo dell’autunno, come un atteso temporale che proietti in dimensioni altre, torno alla mia indagine tra le acque dolci salate e salmastre delle arti visive. Quello che mi interessa, e che cerco – o esploro – qui, è forse la relazione sottocutanea, invisibile e per questo per me molto autentica, delle autrici e degli autori che percepisco come acquatici non solo per i soggetti o i temi delle loro ricerche, ma per qualcosa che avviene anche nel loro praticare ed esistere il Pianeta Terra, che sta nella loro storia, nel loro percorso e che percepisco in molte forme – quasi mai troppo descrittive – nei loro lavori.
Stavolta nuoto nel Mediterraneo – vivo e pulsante di polvere, roccia e materia organica – di Assunta D’Urzo e tra le sponde – paludose, fitte, pungenti e labirintiche – del Delta del Danubio di Camilla De Maffei.
Assunta D’Urzo nasce a Torre del Greco (NA) nel 1982. Laureata prima in Lettere Moderne e poi in Fotografia, partecipa alla prima edizione del Laboratorio Irregolare di Antonio Biasiucci, e lì ci conosciamo – esattamente dieci anni fa. Con Assunta abbiamo condiviso un percorso di crescita pieno di confronti. Ricordo ancora una lunghissima chiacchierata sul porto di Ischia in cui parlammo del “muoversi su un territorio comune”, territorio che – pur proiettandosi in immaginari interiorizzati – probabilmente non aveva collegamenti con i temi di ricerca ma con il metodo, gli intenti della nostra necessità di fare ricerca. L’indagine di Assunta D’Urzo è sullo spazio quotidiano, sull’esperienza dei limiti, ambientali e sociali, che sfidano lo spirito adattivo degli uomini. È l’esplorazione di quei margini che offre al suo sguardo paesaggi di insperata libertà, tendendo alla ricerca di una scrittura per raccontare il corpomondo . Il corpomondo è per D’Urzo un codice in costruzione: l’autrice percepisce – nella sua pratica artistica – che se inquadra un braccio o un seno o una spalla da qualche altra parte – nel mondo – le risponderà qualcos’altro: un piede di monte o una schiena di animale o un tronco d’albero o un muro. L’acqua nei suoi progetti appare poco, perché è sempre altro: prende la forma di quello che l’autrice le dà. Ed è il filtro di quello che vede trasfigurato, essendo presente nella trasformazione delle cose\soggetto che D’Urzo fotografa. E disegna.
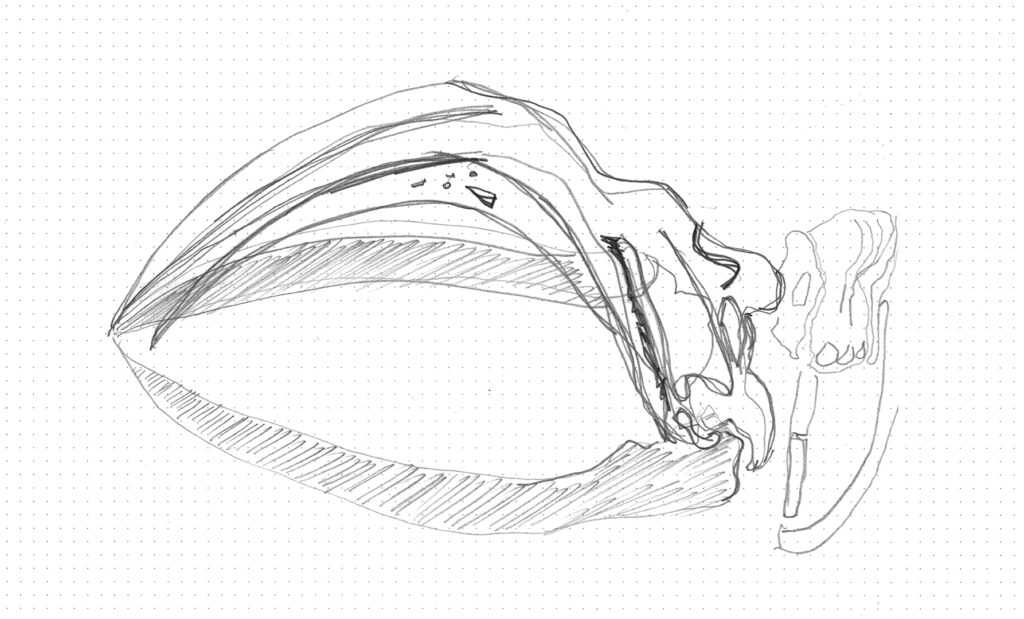
Chiara Arturo: Che rapporto hai con l’acqua? Che relazione c’è tra il tuo rapporto con l’acqua e l’essere nata a Torre del Greco? E come vivi il rapporto con l’acqua, ora, a Torino?
Assunta D’Urzo: Il mio rapporto con l’acqua è visivo e olfattivo. Cerco il mare per guardarlo, soprattutto. Salgo e scendo i promontori per trovare il mio punto di osservazione. Un punto fermo, che posso ritrovare. Cerco la vegetazione di alcune coste che odora e grida il suo profumo e sembra trattenere il sale. Amo le spine dei fichi d’India e il loro succo. Sono felice quando cammino attaccata ai palazzi scorticati dalla salsedine, trasformati dall’umidità.
Amo essere circondata dal mare e amo trovare una via di fuga per gli occhi.
Li scaravento in acqua. Li lavo.
D’estate non andavamo in vacanza in un’altra città. I miei mi portavano alle spiagge di Torre del Greco. Invidiavo chi partiva per la Calabria, ma l’invidia finiva quando mi ritrovavo a mare. Quando mamma e papà parcheggiavano la Panda sotto ai pergolati di fico, io lo sentivo già: era nella freschezza e nell’aroma di quell’ombreggiatura che ho trovato ripetutamente altrove. Il mare era un’altra dimensione, una bolla che mi separava da tutto quello che non mi piaceva della mia vita. Era avventura instancabile, gelati alla frutta e tanta bella malinconia. Guardando il mare, al momento del saluto che avveniva intorno alle 17, credo di aver provato inconsapevolmente malinconie, nostalgie. L’assenza di giudizio era la fine del sole bruciante, era il vento che asciuga il costume. Una dimensione che non è naturale rispetto alla fatica che invece è pervasiva.
Da piccola l’attaccamento fisico al liquido era totale. Quando sono cresciuta non sopportavo l’acqua inquinata e il rapporto tattile con l’elemento si è trasferito sulla ricerca visiva e olfattiva: un modo diverso per ritrovare il posto sicuro in cui sentire tutta me, la mia esistenza, la libertà di poter essere. La prima volta che ho avuto una specie di attacco d’ansia, di sera, ero appena scesa dal treno e avevo vent’anni, ho capito che avrei potuto gettare ogni cosa a mare.
A Torino casa è a dieci minuti dal fiume e la relazione è la stessa che ho a Torre del Greco. Una relazione monotona, monacale, meditativa; che esclude il resto della città. Percorro il fiume, ne calpesto le rive, passo sopra e anche sotto i ponti, questo grazie al canottaggio che pratico tre volte alla settimana. La mia prestazione sportiva non è in questione, quanto forse la possibilità di esplorare il Po delle Amazzoni; quello che va verso Moncalieri attraversa dei tratti tropicali e ha nidi di folaghe e aironi sull’acqua. L’acqua descrive e ospita un confine nella città dove mi ritrovo. Una vita altra, dove c’è un senso di infinitezza delle esperienze. Ricordo il racconto del prof. Varvaro all’Università di Lettere che ci raccontava le storie cavalleresche: il momento fatidico in cui il cavaliere scorgeva la dama del lago. Entrava nello specchio d’acqua e quando ne usciva erano passati vent’anni.
Torino fa parte di questa educazione liquida. Forse. Son salita qui che volevo arrampicarmi sulle montagne. Montagne che hanno conosciuto il mare, ne sono emerse. Alcune delle loro parti continuano ad essere bagnate e umide (il primo film che ho visto a Torino, stranamente, è stato “Il buco” di Michelangelo Frammartino). Potremmo considerarle anfibie, sirene. Mi sembra che io abbia voluto salire per vedere tutto dall’alto.
“La trota legge tutto quello che viene da monte come il futuro”.
(Paolo Cognetti, Le otto montagne)

Essendo, come si evince, una persona abbastanza nostalgica, in bilico tra due dimensioni, la montagna mi riporta un po’ al tempo, ai secondi. Vedo la montagna come quella che è riuscita a emanciparsi cozzando, scontrandosi con le altre zolle. È riuscita a “spuntarla”.
E c’è una mia parte che dice: puoi stare anche tu senza?
Oppure dice: solo mare? Solo quello? Resti lì?
O ancora: sfidare la bellezza. Starci lontana.
Ad ogni modo, forse senza mare, ma non senza acqua. Potrei adeguarmi a fonti d’acqua secondarie e vassalle e legarmici esclusivamente e devotamente. Difendendole, se serve, anche dall’Oceano.
CA: Ci sono altri luoghi acquatici o forme dell’acqua a cui ti senti particolarmente ancorata?
ADU: In alcuni momenti percepisco la pioggia come regalo. Come un evento miracoloso.
Mentre si lavora o si cammina ci si ritrova improvvisamente bagnati. Non abbiamo cercato l’acqua, è lei che ci cade addosso.
Mi piacerebbe visitare un ghiacciaio, perché non ho proprio idea di che cosa mi ritroverò di fronte e come mi sentirò. E questa ignoranza la trovo bella.
Mi piace stare al fiume quando la nebbia sale dall’acqua, è una specie di alba.
Cerco di stare tra gli alberi quando piove. Come una rana nello stagno. Mi ci sento attratta magneticamente, quindi forse ancorata. Il posto che ti tiene al sicuro è il posto dove ti senti libero.
La vasca in sé non era grande, circa come una piscinetta di plastica: cinque metri di lunghezza e più o meno tre di larghezza. Noi scendevamo per una scaletta nell’acqua calda. Dai séparé si guardava direttamente dentro la vasca ed era impossibile vedere al di sopra della superficie. Perciò potevamo tenere la testa fuori dall’acqua e parlare tra noi. A patto di restare immersi dalla vita in giù, i clienti erano soddisfatti. «Non vengono qui per vedere la tua bella faccia» mi spiegò Presto. Il che rendeva tutto più facile. Non credo che avrei potuto esibirmi in un normale peep-show, faccia a faccia con i guardoni. Il loro sguardo mi avrebbe succhiato l’anima. Quand’ero sott’acqua nella vasca tenevo gli occhi chiusi e ondeggiavo nel silenzio degli abissi. Quando premevo con il corpo contro il vetro dell’oblò restavo con la testa fuori dall’acqua per ignorare gli occhi che studiavano il mio mollusco. Come ho detto, prima? La superficie del mare è uno specchio che riflette percorsi evolutivi divergenti. Sopra le creature d’aria, sotto quelle d’acqua. Un unico pianeta che contiene due mondi. I clienti erano le creature marine: Zora, Carmen e io restavamo essenzialmente creature d’aria.
(Cal, da MDLSX di Jeffrey Eugenides)
La sera che ho visto MDLSX a Galleria Toledo era tutto umido, come se mi piovesse in testa e dagli occhi. Fotografai Silvia Calderoni così:

CA: Cosa significano il Mediterraneo, l’orizzonte, il Vesuvio e gli elementi terra e fuoco per te?
ADU: Il Mediterraneo è il mio mare e sono convinta che lo riconoscerei in ogni paese che ne è bagnato. Per ora conosco solo le coste italiane: non ho mai visto Jugoslavia, Albania, Grecia, Turchia, Tunisia, Algeria, Marocco, Spagna. Sono stata in Portogallo perché volevo vedere il punto da cui si lasciava il vecchio continente.
Vedo il Mediterraneo come un lago grande attorno al quale ci sono i paesi. In alcuni di questi paesi ci sono lager a ridosso delle sponde e a poche miglia dalle nostre isole ci sono delle fosse comuni marine. Le coste di alcuni paesi sono le Nuove Colonne d’Ercole. Gli squali hanno lasciato l’Oceano e sono entrati qui.
Per andare in un altro paese sono cambiate le rotte. La geografia è un’altra. Alcuni uomini vivono con l’impossibilità di uscire dal proprio paese. A meno che non ti affidi a chi ti nasconde, e in cambio di una presunta libertà ti lacera.
Non so se l’Orizzonte di queste persone sia sgombro ora che sono approdati nell’Europa mediterranea.
La mia esperienza è diversa. Avevo la certezza di trovare un lavoro migliore.
Ma scavando a fondo c’è una ragione forse sommersa. Guardando il mare e l’Orizzonte mi sono sempre sentita bene, baciata dal sole calante, dalla quiete e non sono mai voluta andare via. Per 39 anni. Ho provato anche e costantemente una grandissima malinconia: come se pensassi: Tutto questo mi basterà?
Ma non come una questione egoistica, era come se pensassi: Mi accomodo? Mi fermo già? Mi riferisco a Napoli, dove bere uno spritz vicino al mare, o fare anche solo una corsa al tramonto ti tiene in vita. E tutto si ferma. Tutto si acquieta nella bellezza e si rigenera. È meraviglioso.
Ma, in una maniera che posso solo considerare viscerale, mi sono chiesta se potevo vivere anche in un altro modo. Se c’è qualcosa che corre più veloce di quella bellezza. Non posso non considerare che, mentre custodivo in me tutto questo, il mare ci ha portato i migranti. Il mare ha cambiato aspetto. Senza retoriche né buonismi. Non potevamo tutti non considerarlo almeno una volta quando ci trovavamo di fronte alle onde, con i piedi ben piantati sul molo. Non erano le navi che venivano da Bisanzio, né quelle da dove sbarcavano i marittimi (tradizione viva del mio paese). Non era ricchezza brutalmente materiale. Era più un oceano che vomitava qualcosa, come la balena di Pinocchio.

Il Mediterraneo forse sarà il risultato di queste due visioni d’Orizzonte: quella mia e quella di un altro appena arrivato qui. Il Mediterraneo sarà quello che insieme proiettiamo sull’acqua: il mio infrangere lo specchio e gli incubi di terra e di acqua di un altro; il potentissimo ringraziamento di chi è felice di essere in questo Paese o una traccia di chi soltanto passa, da qui, per poter attraversare l’Oceano.
(Penso alle mappe di Alighiero Boetti, alle ricamatrici afghane. A quella volta che usarono il filo rosa per tessere il mare; chissà se il blu era finito o era perché loro il mare non l’avevano mai visto. Ad ogni modo sorrido sempre felice quando ripenso a lui, l’artista che trasportava il mondo ovunque, che ricamava con meridiani e paralleli… che delocalizzava il globo).
Mentre nei confronti del Vesuvio ho sempre provato la voglia di attraversarlo, di salirci, di poterlo girare in tondo. Il Vesuvio è pietra viva, lo dimostra anche con il suo fuoco, vivo per se stesso, nel suo uccidere tutto il resto. È estrema luce e solitudine: quando splende noi siamo lontani o fulminati. Quando noi siamo vivi e abbiamo pacificato il fuoco nel nostro sangue e nella terra fertile lui è silenzioso come l’aridità della Valle dell’Inferno, che possiede ancora il clima e il tempo di un mondo appena reciso.
Sono scesa di recente a Torre del Greco, per un matrimonio, e mi sono fiondata sulla spiaggia dove abbondavano le pietre cadute, in una frana ordinata subito sotto i binari del treno. Quelle pietre erano una specie di cascata, di altro mare, un battesimo che fai con le spalle rivolte alle onde.

In quello stesso inferno le Ginestre impazzite di luce (mi perdoni Montale per la citazione rubata al suo girasole) e le api fanno ricominciare il mondo. Nella sua polvere vedo il combattimento e il sangue ricominciare. In Harena c’è una foto notturna del monte di Procida che contiene la speranza delle stelle (Monte dei Campi Flegrei eroso dal mare e arido dei fuochi) a cui associo un cavallo bianco. Mi immagino che dal mescolarsi di oscurità e polvere possa nascere la luce.

CA: Cosa mi dici degli abissi? Perché cerchi la balena e dove sei arrivata finora?
ADU: Gli abissi li conosciamo da prima di aver toccato l’acqua, di aver visto in fondo a un pozzo, o essere stati su una montagna.
Secondo me nasciamo con la paura di cadere, di precipitare. O almeno io.
I miei abissi hanno una configurazione precisa: un immenso Kraken che con i tentacoli mi tira giù rovinosamente. Mi stritola e mi toglie l’aria. Mi copre con la polpa dura e molle insieme.
Ho dato all’abisso un’immagine precisa abbastanza presto. Avevo 4 anni.
La balena è invece the sweetest thing. La creatura protettiva di questo orrore.
Anche lei porta i segni dei combattimenti, della fatica, della possibile estinzione.
È la più forte e delicata.
Come Melville mi ha insegnato, è la sofferenza più estesa che esiste.
Ho smesso di ricercarla su pellicola perché volevo raccontarla agli altri. Per riuscire a tramandare una storia. Io però continuo a vederla e mi perdo e mi ritrovo; nei buchi d’acqua dove possono esserci delle assenze o delle apnee più o meno lunghe. E poi la balena è diventato ciò che balugina improvvisamente. Qualcosa di grande e nascosto che mi appare.
Dove sono arrivata quindi?
Se parliamo d’acqua forse non sono arrivata da nessuna parte.
Ho capito qualcosa di me. La profonda limitatezza di cui sono fatta.
Degli esercizi piccoli di immaginazione che faccio per provare a dare un volto a ciò che potrei non toccare mai.

Da questo Mediterraneo personale, viscerale e celato, trasfigurato in aria terra e fuoco, passiamo a un lavoro in cui l’acqua c’è costantemente, senza essere mai realmente soggetto, ma piuttosto tramite, metafora, simbolo di qualcosa che è altro. Nel Delta di Camilla De Maffei mi immergo e mi perdo, un senso di inquietudine mi attraversa costantemente guardandolo, eppure in qualche modo queste immagini diventano casa, rifugio, sollievo.
Camilla De Maffei nasce a Cles, in Trentino, nel 1981. Ci siamo conosciute nel 2017, durante la residenza artistica ai Bocs Art di Cosenza, rincorrendoci negli anni tra Arles, Barcellona, Milano, Ischia. Insegna fotografia ed è co-fondatrice dello spazio dedicato alla fotografia di ricerca El Observatorio di Barcellona, un laboratorio didattico specializzato in fotografia e narrazione visiva. La sua pratica fotografica non mira a illustrare e descrivere letteralmente, ma a interpretare e attribuire nuovi significati agli elementi quotidiani combinando un approccio documentaristico a narrazioni personali. Dal 2009 concentra il proprio lavoro sui Balcani, con particolare attenzione alla Bosnia Erzegovina, alla Romania e all’Albania. Nei suoi progetti a lungo termine, il suo obiettivo è quello di osservare questi territori da un punto di vista emotivo e insieme culturale e geopolitico, esplorando e mettendo in relazione i concetti di identità, memoria e paesaggio.

In Delta (2014-2021) Camilla De Maffei ha esplorato per anni il delta fluviale più grande d’Europa, quello del Danubio: un labirinto fatto di giunchi e pantani che si estende per oltre 3.500 kmq.
Come minotauri, i pochi abitanti del Delta vivono isolati tra le paludi, in simbiosi con il paesaggio e le sue mutazioni. Lì l’Europa fisicamente finisce, affondando nel Mar Nero – o nell’oscurità che risucchia tutto appena il sole tramonta. Camilla De Maffei, partendo dall’esplorazione di un territorio specifico, attraverso le stagioni, disegna una mappa che interroga il paesaggio ed esplora il significato più profondo dell’atto di abitare – un territorio, un labirinto, se stessi. Il Delta diventa simbolo in sé, lettera che racchiude un mondo tutto da decifrare.
In un labirinto il tempo non scorre in modo familiare. Non avanza, circola. È, ma in spirale.
Pesa, si dilata ed è scandito da azioni ripetitive.
Dal caldo che si trasforma in freddo, dalla luce che diventa buio e poi luce ancora, dal ghiaccio che si scioglie per diventare acqua e poi ghiaccio di nuovo.
Dopo l’inverno ci sarà l’estate. Dopo il gelo il disgelo.
Dopo il dolore, la fine del dolore.
Con il sole la vita, con il freddo la morte. Questa è l’unica certezza.
(Camilla De Maffei, note di campo)

Chiara Arturo: Che rapporto hai con l’acqua?
Camilla De Maffei: È fresca, delicata e forte, ondosa, infinita, è come uno specchio, intensamente blu quando è profonda. A volte è bianca, altri giorni è quasi nera, controluce diventa pura come l’argento vivo.
Amo vederla brillare al sole come un gioiello. È portatrice di promesse. É lo spazio più intimo che possiedo, quello in cui mi sento capace di desiderare senza avere paura.
In lei non ho peso, non mi do peso.
Allargo le braccia, muovo le gambe, mi immergo e sprofondo perché ho sempre voglia di appartenerle.
Ma non sto parlando di acqua e basta, sto parlando del mare.
CA: Che relazione c’è tra il tuo rapporto con l’acqua e il tuo essere per metà sarda e per metà trentina?
CDM: Sono nata in Trentino, ma mia madre è sarda. Si è trasferita a vivere lì quando ha conosciuto mio padre e fin da quando ero bambina ha condiviso con me la sua nostalgia dell’orizzonte.
Fra le montagne lo sguardo è imprigionato, rinchiuso in un spazio finito, gravato dalla presenza verticale delle pareti rocciose.
Il mare invece è infinto e permette agli occhi di spaziare fino ad essere sazi. L’isola è un mondo aperto che invoglia a immaginare, a viaggiare. Davanti all’orizzonte disegnato dal mare ci sei solo tu e quando lo guardi non puoi fare altro che essere te stesso.
«Quando saremo in Sardegna capirai cosa intendo.»
Così, ho passato un’infanzia ignorando le montagne in attesa di tornare su un’isola che paradossalmente non conoscevo e che sentivo più mia del posto in cui sono nata.
Poi il tempo è passato, ho viaggiato abbastanza e mi sono riconciliata con le mie origini trentine.
Da adulta ho trovato una mia dimensione anche in montagna. Il fatto è che prima non la conoscevo per niente. Non l’avevo vissuta né fatta mia.
Adesso ho i miei gusti.
Amo i chiaroscuri del sottobosco, la rugosità dei tronchi degli alberi, il giallo scintillante di certi muschi. Le pietre che emergono dalla terra o dalla neve. L’arrivo dell’inverno e l’odore della terra umida. Le cime degli alberi di notte. Certi piccoli mondi nascosti fra gli abeti che scopri solo dopo ore di cammino.
Nel bosco mi sento molto a mio agio. Del resto anche questo ecosistema fa parte di me ed è stato bello scoprire che lo porto dentro come il mare.
CA: Come vivi il rapporto con l’acqua nei luoghi in cui hai vissuto e vivi?
CDM: Cerco sempre il mare, non importa dove io sia.
Se non è vicino calcolo tra me e me la distanza che ci separa. Lo faccio per abitudine, inconsciamente, senza quasi rendermene conto. È un’unità di misura che mi serve per prendere coscienza delle caratteristiche del luogo che abito o in cui andrò a vivere.
Se è molto lontano dal mare lo sento sento sempre come uno spazio precario, di transizione. Una tappa di avvicinamento al mare.

CA: Come cambia questo rapporto in base al fatto che l’acqua sia di Mar Mediterraneo, di lago, di fiume, allo stato liquido, solido o gassoso?
CDM: Il mar mediterraneo è casa. Il resto non è la stessa cosa. Del lago apprezzo la bellezza, quando ci vado ritrovo il piacere di essere vicina all’acqua, ma le sue rive hanno un sapore malinconico. Una promessa non mantenuta. Un vorrei, ma non posso. È acqua circoscritta, imprigionata, dolce. Non fa per me.

La neve invece è uno dei miei soggetti fotografici preferiti. Sono attratta dalla sua consistenza, dal potere del suo colore bianco. Mi diverte osservare il modo in cui si stende sulle cose per affogarle dentro di sé, o per nasconderle. Vederla cadere, osservare come si accumula e cresce. Da anni la fotografo in tutti i suoi stati, per pura passione, senza pretese.
È un ricordo d’infanzia.
In inverno l’aspettavamo con ansia. Mio fratello e io facevamo previsioni e scommesse. Andavamo a dormire sperando di ritrovarla la mattina dopo, come una sorpresa preparata mentre noi stavamo sognando. A volte succedeva. Il freddo di alcune nottate portava la neve e la giornata che cominciava aveva un sapore diverso. La casa era più casa, più calda e le luci erano più gialle.
Sono rituali da cui è impossibile separarsi. Ormai mi sono abituata ad aspettarla e ancora oggi ho bisogno di vederla cadere per sentire che un ciclo è finito e ne sta per cominciare un altro.
CA: Che ruolo ha l’acqua nel tuo lavoro?
CDM: Sinceramente l’acqua non ha un ruolo particolare nel mio lavoro anche se in alcuni casi è presente.
Diciamo che non la cerco intenzionalmente, ma quando la trovo cerco di raccontarla. Il suo valore simbolico risponde alle necessità del contesto.

In Delta, per esempio, l’acqua è una costante silenziosa. Si potrebbe dire che costituisce il 90% del paesaggio e – anche se in modo impercettibile – è l’elemento più potente del racconto.
Nel progetto esploro cosa significhi abitare il delta del Danubio, il più grande estuario d’Europa: un labirinto naturale fatto d’acqua e di giunchi che si estende per 3500 kmq, fino al mar Nero.
La regione è abitata all’incirca da 14.000 persone che vivono sparse fra villaggi privi di infrastrutture di base e spesso raggiungibili solo in barca.
Per anni, in estate e in inverno, mi sono immersa in questo imponente paesaggio acquoso per osservare e documentare le sue mutazioni.
Il caldo rende l’acqua verde o grigio scuro. In agosto è carica di zanzare e si muove melmosa fra i giunchi e la sabbia bollente. Si può navigare e la sua durezza selvaggia ha qualcosa di accogliente, di facile. Poi arriva l’inverno e il Danubio lentamente si ghiaccia. L’acqua allora diventa bianca e solida, abitata da geometrie di ghiaccio, affilate e rotonde.
Mi piaceva restare seduta sulla riva dei canali a osservarle scorrere, il loro passaggio fa un leggero inconfondibile rumore.
C’è vuoto e lo si percepisce spesso come una presenza in più. Come un dito che segnala un’assenza. Non ci sono abituata e mi pesa terribilmente. Spesso ho l’impressione che il Delta intero sia immerso in un profondo letargo. Le mie passeggiate quotidiane sono piuttosto derive fra case e giardini alla ricerca di un incontro, di qualcuno. Intravedo gente che cammina lontano, ragazzi che si aggirano su carretti. Rumori di bicicletta, uomini carichi di pezzi di ricambio, donne con la spesa. Nessuno mi rivolge la parola però sapere che ci sono mi fa compagnia. Credo di non aver mai sperimentato un senso di smarrimento così forte. Mi dico che non devo, ma mi sento sola lo stesso.
(Camilla De Maffei, note di campo)
Con il tempo ho imparato quanto la vita degli abitanti del Delta segua il ritmo regolare e inevitabile dei cicli naturali. Le mutazioni dell’acqua – e quindi del paesaggio – ne influenzano gli stati d’animo, le abitudini e stabiliscono barriere fisiche e mentali. Dopo il gelo, il disgelo. Le stagioni condizionano le mancanze, i desideri, le paure di tutti. Con il sole l’acqua scorre e con lei la vita, il contatto, l’empatia. Le speranze sembrano esplodere. Con il freddo sopraggiunge la solitudine, la mancanza, il senso di lontananza e in alcuni casi, la morte. L’acqua è immobile e silenziosa.

Ho cercato con tutte le mie forze di tradurre nelle mie immagini la maestosa bellezza di questa ciclicità. Tanto il libro come la mostra sono costruiti secondo una struttura circolare: cominciano con il verde rigoglioso dell’estate e lentamente trasportano lo spettatore attraverso il rosso spento dell’autunno. Al centro c’è il bianco abbagliante della neve e il silenzio che questa porta con sé. Poi tutto comincia a rifiorire, il giallo e il blu ritornano per spegnersi nel caldo di una nuova estate.
CA: Come si trasforma la tua pratica quando torni in Sardegna?
CDM: Quando sono in Sardegna mi lascio trasportare da quello che vedo, senza impormi la responsabilità di “raccontare”. Ho un legame ancestrale con il paesaggio. È casa, è utero, è famiglia. Sono mossa dall’istinto e mi godo ciò che vedo attraverso il semplice gesto di scattare una fotografia. È un modo di farne parte, di essere attiva nel guardare. Questa semplicità mi regala una pace profonda. Mi riconcilia con la fotografia, con la purezza dell’atto di vedere in tutta la sua sincerità. Non ci sono perché. Non c’è un modo giusto di farlo.
A Bosa, il paese della mia famiglia, c’è un luogo che amo specialmente, si chiama Cane Malu.
È un territorio lunare e sassoso a picco sul mare. Desertico, aspro, colorato.
Lo trovo di una bellezza sorprendente e ogni anno lo fotografo per rendere reale il rituale del nostro incontro. Quando torno niente è cambiato, tutto è rimasto al suo posto, ma sento comunque il bisogno di possederlo in ogni minimo dettaglio. Spesso rifaccio le stesse foto, con angolature diverse, ma non mi importa. Fa parte del gioco.
La cosa interessante è che non fotografo mai il mare, che pure è li a pochi passi.
Non importa, l’aspetto lunare del paesaggio e luce che riflette a mezzogiorno racconta meglio il Mediterraneo di una qualsiasi fotografia dell’acqua.

“Altre acque – itinerari non terrestri” è un’indagine – spinta dalla corrente – tra le acque dolci salate e salmastre delle arti visive che continuerà, nei prossimi mesi, a cadenza irregolare.




