Un dialogo con Francesca Loprieno
Francesca, riprendo il filo delle tue riflessioni sul mio lavoro e delle analogie che proponi con il tuo, nel tentativo di tracciare sentieri, seppure interrotti, di un dialogo a distanza.
Mi sembra naturale cominciare dal titolo che hai scelto, che coglie perfettamente il punto d’incrocio più evidente delle nostre ricerche artistiche: la poetica della frontiera. Prendendo posizione su questo crocevia da te suggerito, cercherò di far luce su quello che so, o credo di sapere, del mio approccio e su quello che mi sembra di cogliere del tuo.
Mi sono sempre interessato alla nozione di frontiera. Direi senz’altro che questa tematica è il leitmotiv di gran parte dei lavori che ho realizzato fino ad oggi: Asmara Dream, Cronotopie, Les pas perdus, The Interzone, per citarne alcuni. La frontiera, l’intervallo, il frammezzo, lo spazio del ‘tra’: altrettanti modi di dire o di evocare questo concetto che, non bisogna dimenticarlo, ha una duplice valenza, spaziale e temporale. El Bahr presenta la distesa del mare come questo spazio intermedio, e l’orizzonte marino come suo limite allo stesso tempo infinito ed effimero (per effetto di traslazione). Al di là degli elementi di documentazione di un territorio geografico ben determinato (quello della costa del Marocco, dall’estremo sud del paese fino alla frontiera con l’Algeria), questa serie di venti immagini, che – mi sembra importante sottolinearlo – hanno un formato considerevole (118×145 cm), intende farci fare l’esperienza di un territorio che è, come lo ricordi giustamente, innanzitutto un territorio dell’anima, ovvero uno spazio interiore.
L’orizzonte rappresenta qui la soglia tra ciò che è visibile (al-di-qua) e ciò che è invisibile (al-di-là) eppure ben presente in quanto oggetto ‘fantasmatico’ di proiezione. Le immagini ci mostrano degli individui (uomini o donne di diverse età e di diversa estrazione sociale) di fronte al mare, fotografati di spalle. Mentre i particolari del paesaggio costiero e i dettagli del loro abbigliamento ci appaiono ben visibili, i loro volti ci restano nascosti, così come i loro occhi, che possiamo immaginare però concentrati sulla linea dell’orizzonte.
In noi che ne siamo spettatori, lo stato di assorbimento silenzioso di questi individui nella contemplazione del paesaggio marino libera, in una sorta di mise en abime, lo spazio dell’immaginario. Non possiamo non pensare, in questo senso, alle tele di Caspar David Friedrich, in particolare al celebre Viandante sul mare di nebbia (1818).
Il fatto che le persone siano ritratte sempre di spalle è tutt’altro che secondario: la postura di spalle, come spiega Georges Banu nel suo saggio L’homme de dos (2001), fa sì che le persone fotografate, venendo meno gli attributi che contribuiscono ad individualizzarle, diventino ‘personaggi’, quindi oggetti di proiezione immaginaria.

El Bahr aspira pertanto ad essere una poetica della frontiera, precisamente nel senso in cui poiesisin greco vuol dire fare, mettere in forma, ‘dar materia’ più che suggerire con le parole. La temporalità di questa serie – come quella che emerge da altri miei lavori (in particolare Sospensioni, Metafisica, Les Baumettes) e che mi sembra trasparire anche da alcune delle tue immagini (quelle di Harnes, per esempio) – è una temporalità che si potrebbe definire ‘sospesa’; un’esperienza simile a quella che possiamo fare di fronte ai Peppers di Weston o alle marine di Sugimoto: una temporalità orizzontale insistente in quanto la presenza dell’oggetto fotografato (paesaggio o natura morta che sia) si prolunga indefinitamente sotto il nostro sguardo, guadagnando progressivamente spessore. A differenza del presente dell’instantanea, puntiforme e incompleto, qui abbiamo a che fare con un presente disteso e in un certo senso inesauribile. Si tratta di quella modalità della presenza che Gilles Deleuze, riferendosi precisamente alla natura morta cinematografica (illustrata dal piano fisso del vaso di porcellana nel film Tarda primavera di Yasujiro Ozu) considerava come la migliore immagine della durata: «le nature morte di Ozu durano, hanno una durata, i dieci secondi del vaso: questa durata del vaso è precisamente la rappresentazione di ciò che permane attraverso la successione di stati mutevoli» (G. Deleuze, L’immagine-tempo, Ubulibri, Milano, 1989, pp. 28-29).

Più che altri miei lavori, El Bahr ha una struttura inequivocabilmente seriale, che si concretizza nel carattere ripetitivo della composizione e dell’inquadratura. Direi di più: c’è qualcosa, nella costruzione di questo lavoro, del gesto del collezionista – gesto che mi sembra analogo, in fondo, a quello del fotografo. Soltanto l’oggetto – qui immagini fotografiche, lì francobolli, o qualunque altro oggetto di desiderio compulsivo – mi pare distinguerli. Il lavoro di archiviazione è, del resto, un altro punto di contatto evidente tra le due attività.
Per rispondere alla tua domanda sull’origine di «queste pose delicate e rispettose», come le definisci, le immagini di El Bahr sono il risultato di una lunga e assidua frequentazione di questi territori di confine tra la terra e il mare, alla ricerca di quelle situazioni in cui l’assorbimento nella contemplazione del mare accede al visibile. Questi momenti privilegiati, che sono diventati a volte veri e propri incontri umani, non sono stato io a provocarli direttamente ma sono il frutto, oltre che del caso, di una paziente e laboriosa attesa.
Mi chiedi anche che cosa ho trovato osservando per ben tre anni tutte queste persone che contemplano il mare. Ti confesso che, in tutto il tempo che ho frequentato questi luoghi di attraversamento, non ho trovato nient’altro che il mistero dell’Aperto che produce ogni volta su di me – come su tutti coloro che si pongo umilmente in ascolto – la contemplazione della prodigiosa massa d’acqua che circonda le nostre terre e che, separandoci, ci unisce. Il mare è per me questo mistero.
Ma veniamo a Les pas perdus, il secondo lavoro che menzioni nel tuo testo e la cui realizzazione precede di poco El Bahr. Qui la frontiera è lo spazio attraversato dal migrante, da chi ha perso la propria identità, ridotta ad essere quella di colui-che-attraversa e che non ha volto, né comunità di appartenenza. Luogo, o piuttosto non-luogo, nel senso di Marc Augé: materializzato nella zona internazionale del porto di Tangeri come appariva prima dei lavori di riqualificazione urbana del 2011. Qui il punto di vista non è più orizzontale, ma dominante (dall’alto verso il basso), mima lo sguardo, neutro e oggettivante, di una camera di sorveglianza, una di quelle ormai onnipresenti nei nostri luoghi pubblici (i quali finiscono per assomigliare, sempre di più e non solo metaforicamente a luoghi di reclusione). Gli individui che percepiamo in queste immagini, ridotti a silhouette spersonalizzate, ci appaiono allora come marionette nelle mani di un destino insensato. La città che fa da sfondo al loro vagabondare (Tangeri, ma potrebbe essere anche Marsiglia, o Napoli) non offre altro che terrains vagues, barriere architettoniche e linee di demarcazione. Il suolo è arido, la vegetazione quasi assente, il mare ostile. Resta solo il cielo, dove corrono le nuvole, come spazio (condiviso) di libertà.
Il non-luogo in cui prende forma davanti ai nostri occhi il «teatro delle marionette», per dirla con Rilke, de Les pas perdus ha indubbiamente qualcosa in comune con la neutralità grigia dello spazio urbano in cui si dispiega la tua serie Transizioni. «L’incessante scorrere della vita umana» segna, come dici tu, la trasformazione del luogo, ma la segna solo provvisoriamente: le traiettorie umane non lasciano traccia del loro passaggio, e nulla sappiamo e sapremo mai delle vite di questi passanti anonimi.
La disumanizzazione dello spazio urbano mi fa pensare anche, forse non a torto, ai tuoi dittici di Beirut; città che definisci, con attributi contrastanti (dittici verbali?), «dolorosa e bella», «sogno mancato, terra promessa e tradita». Queste qualificazioni antitetiche esprimono bene a mio parere lo scarto tra l’immaginazione e la realtà, tra la proiezione fantasmatica di un luogo, quale che sia, e l’esperienza che ne possiamo fare e che si rivela inevitabilmente deludente: la nostalgia di un impossibile ritorno.
La frontiera nella sua valenza temporale – come intermezzo che separa l’immagine fissa dall’immagine in movimento, la fotografia dal cinematografo – mi sembra costituire una seconda dimensione riflessiva di questa serie che, non a caso, hai intitolato Invisible Walls; in questo, la avvicina all’altro mio lavoro che evochi nel tuo testo, gli Arrêts sur images. In entrambe le serie è questione infatti di quel «muro» invisibile che separa una fotografia dall’altra (o un fotogramma dall’altro): un «muro» che – come ogni autentica frontiera – è una membrana permeabile, la quale più che bloccare il passaggio lo rende di fatto possibile (come ricorda giustamente Régis Debray nel suo saggio Éloge des frontières).
Nel raggruppare, come in un montaggio cinematografico, due paesaggi diversi e nondimeno affini («un paesaggio e poi lo stesso», scriveva Denis Roche nella prefazione al libro di Bernard Plossu Les paysages intermédiaires), i tuoi dittici rendono sensibile il passaggio del tempo, l’intervallo che separa un’immagine dall’altra, un luogo dall’altro.
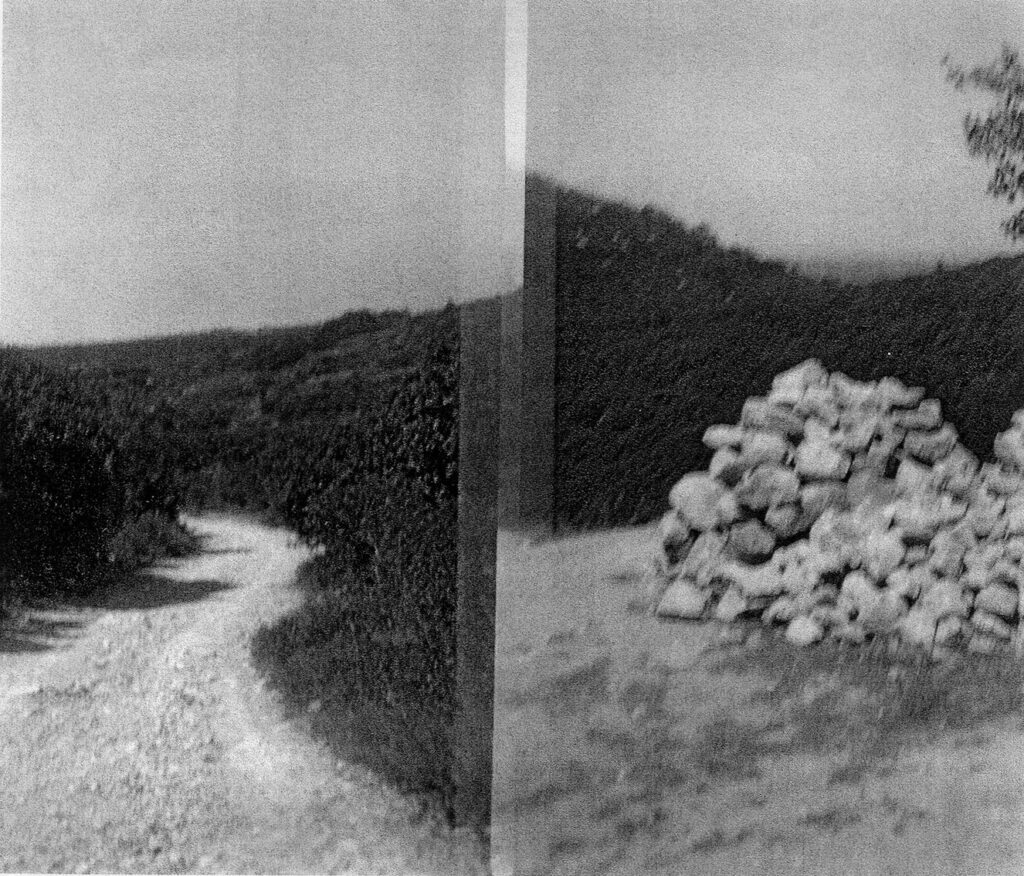
Bernard Plossu, inedito, Madrid, 2002), courtesy dell’autore
Perciò se nei nostri due lavori (Arrêts sur images e Invisible Walls) l’operazione è la stessa – quella cioè di estrarre uno o più fotogrammi da un’unità filmica, conferendogli uno status fotografico – il movimento è diverso, anzi opposto: laddove tu presenti una sorta di montaggio o di dialogo tra due fotogrammi (due spazi-tempo) diversi, io estraggo un solo fotogramma da ciascuno dei corto-metraggi precedentemente realizzati, condensando in un’unica immagine l’intera durata del film. In questo senso, mi sembra che il problema all’origine dei miei fermo-immagine sia analogo a quello che motiva le fotografie del Train de lumière di Bernard Plossu: come restituire il passaggio in una sola immagine? Detto altrimenti: come evocare il movimento attraverso l’immobilità? Lo stesso interrogativo mi sembra di ritrovarlo anche nella tua serie fotografica intitolata 471.


courtesy dell’autore

Una parola infine sulla definizione della fotografia con cui si conclude il tuo testo: «un frammento di tempo di uno spazio indefinito nella realtà e finito solo nella nostra memoria». È tutt’altro che facile racchiudere in poche linee l’essenza della pratica fotografica e del suo risultato. Mi sembra che, mettendo assieme la dimensione spaziale e la dimensione temporale dell’atto fotografico e rilevando l’opposizione tra l’infinito del reale e la finitezza dell’inquadratura, tu ci sia riuscita benissimo. È su questo spazio limitato del fotogramma in cui, prodigiosamente, finito e infinito vengono a coincidere come sulla linea dell’orizzonte del mare, che si chiudono queste mie riflessioni.
À suivre…




