Continuano, in questa seconda parte, i ricordi di Sergio Grazzani fotografo e stampatore di Ugo Mulas dal 1970 al 1973, anno in cui Mulas morì. Il racconto si sposta qui su un piano più intimo che passa attraverso la breve esperienza di “assistente” per tornare a riparlare delle Verifche. Per quanto incomprese allora dal giovane Grazzani, lavorare a stretto contatto con Mulas sulle Verifiche lo segnò profondamente, a testimonianza di quanto i temi affrontati dal fotografo bresciano in quella ricerca fossero fondamentali nel percorso professionale e artistico di un autore.
Giovanna Gammarota – Dimmi di quando hai lavorato come assistente di Mulas.
Sergio Grazzani – Finalmente anch’io ebbi la mia occasione, quando Ugo realizzò un servizio per la stilista Mila Schön a Roma. Sapeva quanto fremessi per fare l’assistente, che stare sempre in camera oscura mi pesava e che volevo imparare a usare le macchine fotografiche, le luci, stare fuori. Quindi mi portò con sé. Arrivammo e per prima cosa lui era preoccupato perché faceva molto caldo. Alloggiavamo in due alberghi distinti: il suo con l’aria condizionata, il mio, un po’ più modesto, senza. Continuava a chiedermi se avevo dormito bene e se faceva troppo caldo, giustificandosi per non aver potuto prendere lo stesso albergo anche per me. Non stava bene e aveva bisogno del fresco. Si preoccupava e si sentiva in imbarazzo perché il suo assistente si trovava in una condizione più disagiata. Io nemmeno ci pensavo, avevo vent’anni. Ormai erano già diversi mesi che lavoravamo insieme, trovai questa sua attenzione molto umana.
Mila Schön era Mila Schön, mica la Standa. Le finestre dello showroom erano grandi e luminose, io mi domandavo dove avrebbe fatto le foto. Tutto era molto eccitante per me. Lui mise la modella vicino alle finestre, posizionò i flash poi andò nella casa difronte, dove c’era un parrucchiere con un bel balcone. I passanti guardavano curiosi quest’uomo con la mano alzata che abbassava nel momento dello scatto: era il segnale per me, dovevo far partire i flash. Per ogni nuovo vestito indossato dalla modella Ugo scendeva in negozio, osservava attentamente ogni cosa, poi tornava sul balcone e dava indicazioni a gesti. Tutta una parte del servizio la fece così, andando avanti e indietro dal negozio al balcone. A cena mi portava nelle trattorie di Trastevere dove spesso trovava qualche artista che conosceva. In quei momenti era davvero una persona amabile, un gran conversatore, ma anche un grande ascoltatore. La sera andava quasi sempre da Toti Scialoja che era suo amico e a volte lo seguivo anch’io. Loro erano due intellettuali che se la raccontavano, io ero la giovane spugna che assorbiva. Mulas con me era, come dire, molto morbido. Anzi nei momenti in cui non si lavorava, come in quelle sere, e si stava insieme alcune ore era veramente un uomo di grande cordialità.
Parlava del suo lavoro, degli artisti, mi raccontava le cose un po’ come se fossi un suo studente. Io gli parlavo di un amico mio, poeta: “sai, gli dicevo, ho un amico poeta” – “e cosa scrive?” – “mah… scrive delle cose, è comunista, un po’ alla Majakovskij, non si capisce niente. Malinconico, molto triste”. Non passò molto che mi regalò tutta la raccolta delle poesie di Ungaretti! Possedeva questo impeto didattico, non so se lo facesse anche con altri, ma ricordo distintamente che spessissimo, quando si parlava di un argomento di cui io sapevo poco e di cui lui notava che avrei voluto saperne di più, ecco che mi procurava la materia prima per studiare. I libri!

GG – Com’era il vostro rapporto “sociale”, c’era distanza tra voi?
SG – Sapeva di avere a che fare con un figlio di proletari, mettiamola così, un figlio di operai. Mio padre faceva il muratore, e dopo alcuni mesi che lavoravo con Ugo si parlò di vacanze. Mi chiese dove sarei andato, lo studio chiudeva. “Non vado da nessuna parte perché non ho soldi”. Qualche giorno dopo venne da me e mi disse: “Senti Sergio, c’è un fotografo che ha fatto un lavoro in bianco e nero, sarebbe da stampare. Se vuoi farlo tu qui, il sabato e la domenica. Guarda che ti pagano, è un lavoro supplementare. Ti anticipo io il compenso”. Ho stampato questi negativi al meglio, impiegando parecchie giornate che poi Ugo mi pagò tantissimo. Secondo me aveva barato mettendo anche del suo. In un’altra occasione questo aspetto di ‘classe sociale’ lo aveva disturbato parecchio. Fu quando andammo appunto a Roma, per Mila Schön e una sera, stava fotografando il marchio sulla porta, c’era una commessa giovane, carina, perfettina, che ci stava assillando raccontandoci che era studentessa però lavorava per arrotondare. Io mi sentivo a disagio: lavoravo da quando avevo quindici anni, ero praticamente un operaio della fotografia, venivo da una famiglia di cinque figli… Ugo se ne rese conto e a un certo punto tagliò corto dicendo: “Va bene abbiamo finito, arrivederci. Andiamo!” Poi in strada: “Sono insopportabili questi figli di piccoli borghesi, superficiali. Non dargli retta”.
Era generoso e disponibile, non sembrava avere molto il senso del possesso, sapeva cosa significasse dover lavorare per vivere. Per questo a volte mi diceva di prendere le sue macchine fotografiche e di usarle. Volevo fare il fotografo. Ricordo che una volta scattai alcune vedute dal terrazzo dove abitavo con i miei genitori, feci dei montaggi che a me piacevano molto e glieli portai a vedere, volevo un suo giudizio. Lui le guardò con molta attenzione. “Belle – disse – però, se vuoi imparare a fare il fotografo, non puoi fotografare qualunque cosa. Devi trovare la tua strada senza perderti in esperimenti belli ma inutili”.

C’è stato un momento in cui volevo andarmene, ero stufo, non volevo più fare lo stampatore. Anche lui però era in una situazione delicata. Non stava bene, doveva partire per New York dove si sarebbe sottoposto a un intervento delicato. Ma io ero deciso a licenziarmi. Il divario tra me e i miei amici che studiavano, viaggiavano all’estero, mi rendeva insofferente. Volevo cercare in qualche modo di recuperare il gap culturale che mi separava da loro! Prontamente Ugo mi propose di lavorare part time. “Ti do gli stessi soldi – disse – così hai il pomeriggio per studiare”. L’ultimo anno con lui lo feci così. Aveva bisogno più che mai di me in quel momento e io non me la sono sentita di lasciarlo. È stato il periodo in cui dovette fermarsi a causa della malattia potendo dedicarsi a ciò che gli stava più a cuore, come le Verifiche.
GG – Ecco che tornano le Verifiche, il suo testamento intellettuale oltre che artistico.
SG – Le Verifiche non sono nate dall’oggi al domani. In studio c’era da fare il lavoro routinario, poi c’era la preparazione della mostra di Parma e poi, ogni tanto, Ugo arrivava con un’idea su questo lavoro di ricerca che voleva fare. Non mi diceva chiaramente quale numero delle verifiche fosse. Si sviluppava quel che aveva fotografato e poi bisognava trovare delle soluzioni per rendere in stampa ciò che aveva in mente. Ti racconto la storia, per certi versi divertente, del martello usato per l’ultima verifica, quella dedicata a Marcel Duchamp. È stata l’ultima che abbiamo stampato e bisognava rompere il vetro che era servito per tanti negativi. Questa rottura identificava la fine delle Verifiche.
Eravamo soli. Abbiamo sistemato i negativi sotto il filtro rosso e c’era da rompere questo vetro. Era un momento delicatissimo. Avevamo quattro attrezzi in studio, arrivo in camera oscura con il martello e lui mi dice: “spacca il vetro”. E io: “col cavolo che spacco il vetro!” Figurati se volevo dare io la martellata! Gli passo il martello: “fallo tu”. Lui dà una martellata e non succede niente, il vetro rimane assolutamente intonso. E se non si rompe o si rompe male? Se si spacca solo in due? Non era un’operazione che potevi ripetere dieci volte. O andava bene o andava male. Allora ho suggerito: “Ugo, forse dobbiamo un po’ sollevarlo questo vetro, che faccia un po’ di conca, così quando dai il colpo si rompe meglio. Infatti abbiamo messo quattro scatole agli angoli poi abbiamo avvolto il martello in un panno perché il colpo fosse meno secco. Ricordo che c’era una tensione pazzesca, aveva paura di sbagliare perché quell’atto era il sugello di tutto il lavoro. Ha vibrato il colpo, preciso, e subito il vetro s’è frantumato. Contemporaneamente ha lanciato un urlo liberatorio! Ma non era veramente finita bisognava esporre.
In genere applicavamo un metodo strano durante l’esposizione, non usavamo l’orologio, contavamo a mente, 101, 102, 103… 110… 120, 130… Facemmo così anche quella volta e dopo questa operazione, nel silenzio più totale, immergemmo il foglio nello sviluppo per qualche minuto. A volte, nel lavorare, succedeva che con le dita bagnate dai liquidi si sfregava una parte un po’ indietro per tirarla un po’ su, era normale sporcarsi le mani. Dunque, in quel silenzio, ci domandammo se la stampa fosse pronta. Tolto dallo sviluppo e lavato bene, misi il foglio nel fissaggio, un’operazione delicata, bisognava stare attenti a non macchiarlo: era una stampa unica. Aspettammo ancora il tempo necessario per poter accendere la luce e guardare il risultato. “Va bene. – sentenziò Ugo – Adesso vado a riposare perché sono molto stanco”. In quel momento, io l’ho pensata così, con quella martellata finivano le Verifiche ma finiva anche qualcos’altro. È stata la sua ultima fotografia come autore.

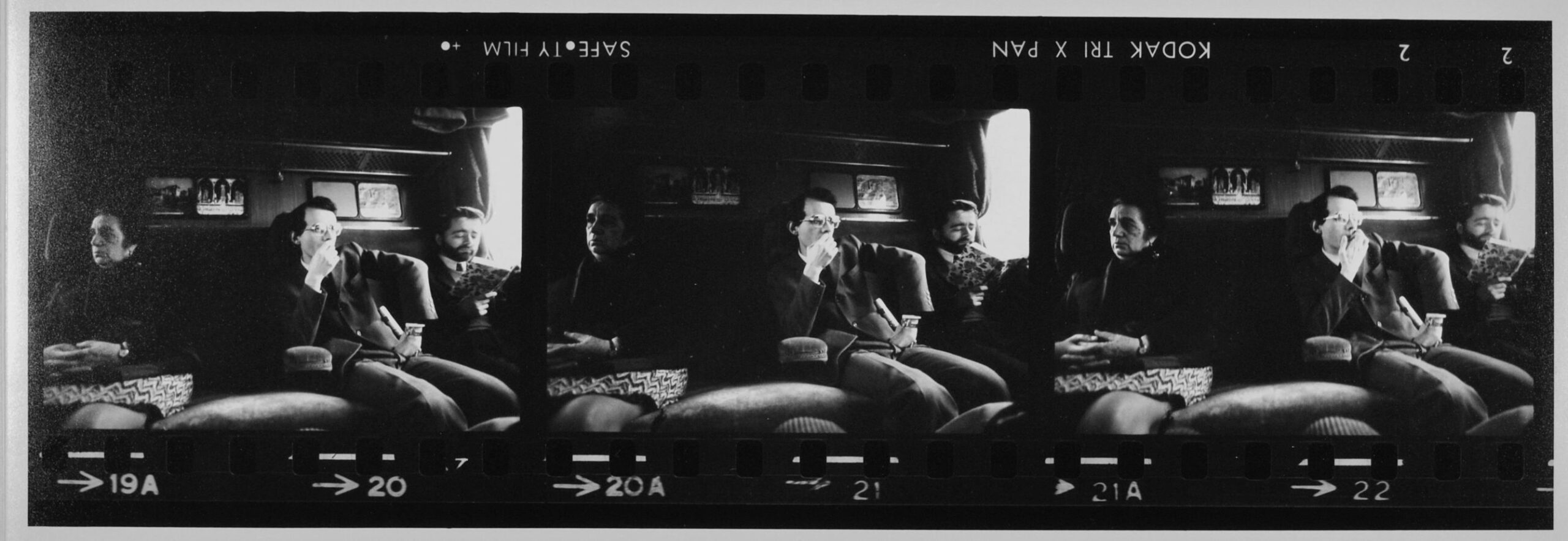
GG – Come vuoi concludere questo tuo intenso ricordo di Mulas?
SG – Vorrei tornare ai ricordi in camera oscura, il luogo dove preferiva trascorrere il suo tempo, secondo me. Era noto che dallo studio Mulas uscivano stampe in bianco e nero di altissima qualità. Questo lo distingueva nel panorama generale dei fotografi. La camera oscura dello studio rispondeva bene a questa necessità. Appena il tempo glielo permetteva passava ore alla stampa. Quattro ingranditori, grandi vasche per acidi e acqua corrente, una buona diffusione di lampade gialle per rendere l’ambiente il meno “scuro” possibile. Per un profano invece era un posto sconosciuto, buio, con forti odori di prodotti chimici, silenzioso, inospitale. Molto meglio la vivacità e la luminosità della sala di posa. Ma era proprio questo il luogo in cui Ugo raggiungeva quella che considerava la perfezione delle sue foto. Attraverso l’alchimia chimica. Lì, nel silenzio più totale intriso del suo lavorio interiore, del suo pensiero intenso su quel comparire dell’immagine sul foglio bianco immerso nel bagno di sviluppo. Rendere omaggio a questa sua grande passione, raccontare tutto questo è per me il modo migliore di ricordarlo.
Appena andai a lavorare per lui una delle prime cosa che fece fu regalarmi una copia del suo libro New York: arte e persone. “Questo è il mio libro” e me lo ha dato, così, con molta semplicità. Quando lo studio si trasferì da via Spallanzani a Piazza Castello, non so come sia saltata fuori questa storia, non me lo ricordo, lui aveva bisogno di fare dei lavori di muratura e credo d’avergli semplicemente detto che mio padre era un muratore: “Ah, mandami tuo papà!” Era un ottimo muratore mio padre e ha fatto parecchio lavoro in Piazza Castello. E quindi quando tornavo a casa la sera mio padre mi diceva: “è passato Mulas a vedere… l’è on òmm straordinari!”


GG – Tuo padre diceva così
SG – Sì sì, mio padre lo ammirava. Mulas era molto cordiale, alla mano. Poi c’ero di mezzo io e mio padre, insomma, era anche orgoglioso che lavorassi per lui. Metti che con Ugo eravamo in camera oscura, insieme, a stampare a un certo punto mi diceva: “Ah, ho visto tuo padre ieri che lavorava. Che uomo straordinario!” Aveva una grande ammirazione per le persone che lavorano bene, consapevoli del proprio mestiere. Anzi, quella cosa che dicevamo prima della commessina di Mila Schön a Roma, ecco credo che Ugo in quella occasione abbia agito per affetto, come fosse un po’ mio padre.
Quando è morto ho preso la macchina e sono andato a Pozzolengo, al cimitero, a vedere dove lo avevano inumato, semplicemente, poi sono tornato. La mattina dopo sono salito da Nini, lei era distrutta l’ho abbracciata e le ho detto che andavo giù ad aprire lo studio. Bisognava continuare a stampare le foto per la mostra di Parma. Nell’androne ho incontrato Benedetta Barzini, fotomodella e grande amica di Ugo, che saliva. Ci siamo abbracciati. Ecco ho pianto lì, insieme a lei.





